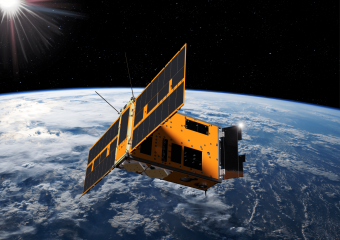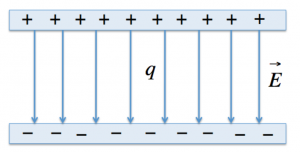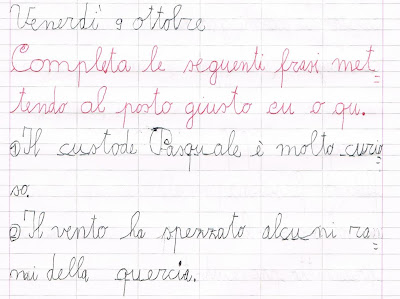Il 28 dicembre 1980, alle ore 15,20 inizia la rivolta nel carcere speciale di Trani
«12 dicembre 1980, è sera, ora di cena. Si cena presto in carcere, televisioni accese a tutto volume, a quell’ora quasi tutte sintonizzate sul telegiornale del terzo canale, quello delle 19.00. Improvvisamente un vociare sempre più intenso, un boato. Ci affacciamo al cancello e contemporaneamente accendiamo la Tv che quella sera, stranamente, tenevamo ancora spenta. Da qualche cella urlano un nome, qualcuno ne declina le funzioni e il ruolo. È un alto funzionario del Ministero della Giustizia con incarichi particolari sulle carceri speciali.
La notizia piove su tutti noi rinfrescandoci, dopo quelle faticose discussioni che avevano arroventato gli animi. Adesso la discussione doveva prendere un altro indirizzo. Ora c’era poco da tergiversare, bisognava confrontarci con la proposta che veniva dall’organizzazione. … …
Proprio la chiusura dell’Asinara tocca una corda sensibile. La solidarietà in carcere non si discute, senza solidarietà in carcere non si vive. L’Asinara, il carcere-lager, la sezione speciale ricavata nella diramazione Fornelli è lo spauracchio di ogni detenuto.
Anche i più duri storcono la bocca quando si minaccia di mandarli all’Asinara. Chiuderla è importante, significa non abbandonare chi vi è finito e versa in una difficile situazione. Lottare contro le carceri speciali e la differenziazione è l’argomento ricorrente nelle discussioni quotidiane.
=*=*=*=
Il racconto della rivolta nel carcere speciale di Trani iniziata il 28 dicembre 1980.
Cronaca della rivolta da: Maelstrom- scene di rivolta e autorganizzazione di classe in Italia (1960-1980)
[dal Capitolo 17- pag. 259]
Ci mettiamo all’opera – Disponiamo le indagini in tre direzioni:
a) lo studio dei movimenti delle guardie per individuare i punti deboli in cui inserire la nostra azione;
b) l’inventario degli strumenti necessari a una rivolta: seghetti, esplosivo, detonatori ecc. in possesso dei prigionieri di quel carcere e l’individuazione dei sistemi per far entrare in carcere ciò di cui siamo sprovvisti;
c) la propaganda nei confronti di tutti i carcerati che faccia emergere la necessità di fare qualcosa di importante per cercare di smantellare le carceri speciali. Nell’opera di propaganda propongo di uscire dalla logica degli aggregati esistenti e di rivolgerci a tutti, in modo da rompere le rigidità precostituite. Operazione di propaganda da fare con intelligenza senza far capire le nostre intenzioni alle guardie ma coinvolgendo tutti i prigionieri.
Per la prima indagine – trovare il punto debole tra i movimenti delle guardie – ci torna utile la grande mole di osservazioni fatte dai detenuti precedentemente. Ci sono dei prigionieri che quando entrano in galera portano con se una sola idea, cercare di fuggire; l’osservazione della struttura carceraria e dei movimenti delle guardie è, per essi, il pane quotidiano. Sono attenti osservatori della struttura muraria e metallica e di tutti i movimenti che si svolgono in carcere. Ogni piccolo particolare viene da loro osservato ripetutamente e memorizzato. Quelle informazioni vengono condivise tra una cerchia di detenuti legati da un rapporto di fiducia saldo, in tal modo si accumula una quantità enorme di sapere carcerario che si può utilizzare per tutte le iniziative contro il carcere. Te ne accorgi quando arrivi in un carcere, se sei una persona fidata, un «bravo ragazzo», ti arrivano immediatamente una massa di informazioni sui cosiddetti punti deboli del sistema di controllo in quell’istituto.
Qualche centinaia di occhi avevano fatto un buon lavoro. La ripetitività pedissequa di ogni struttura militare aveva fatto il resto. Districarsi tra una massa di informazioni e consigli è il lavoro da fare. Si tratta dunque di analizzare queste informazioni per trovare la falla nel sistema di sicurezza e in quel punto costruire l’azione.
L’osservazione su cui lavoriamo si basa sui numeri. Eccola: il rientro dai passeggi dopo l’ora d’aria pomeridiana veniva organizzato in questo modo: tre guardie prelevano due detenuti dal passeggio e li scortano fino alla rotonda della sezione, i due detenuti vengono fatti entrare in sezione e le tre guardie di scorta scendono ai passeggi per scortarne altri due, e così via fino a esaurimento dei detenuti nel passeggio. Ma quando il numero dei detenuti è dispari?
Rimangono gli ultime tre prigionieri nel cortile e le guardie si pongono il dilemma: facciamo ancora due viaggi per scortarli nelle celle, prima due e poi uno, oppure facciamo uno strappo alla regola e li portiamo su tutti e tre? La domanda trova risposta nel bisogno delle guardie di risparmiare una camminata per le scale e guadagnare qualche minuto, poiché dopo aver sbattuto tutti i detenuti nelle celle, chiusi ben bene e fatta «la conta» delle 15.00, le guardie del turno della mattina smontano e se ne vanno a casa.
Questa sì che è una buona falla ed è un buon punto di partenza. Possiamo dunque arrivare alla situazione che tre compagni si trovino in rotonda con tre guardie che possono sequestrare senza tanta difficoltà. Ma poi?
Il progetto della costruenda rivolta si propone di occupare i due piani: il secondo, dove sono i prigionieri politici delle diverse organizzazioni e il primo dove sono i proletari prigionieri. In totale quattro sezioni, due per ogni piano. Altra intenzione è quella di cercare di sequestrare il maggior numero di guardie dato l’impatto che la rivolta avrà sui media e sul governo, poiché fatta in concomitanza con un sequestro di un alto funzionario del Ministero di Giustizia realizzato dalle Br.
Nelle rivolte fatte dai carcerati, che ormai contano oltre dieci anni di pratica, è buona norma sequestrare un certo numero di guardie per tutelare l’incolumità dei rivoltosi. Senza ostaggi i rivoltosi diventano facile bersaglio per il «tiro al piccione». Siamo arrivati al punto che i tre compagni giunti in rotonda possono sequestrare le tre guardie che li scortano, e poi? Poi è necessario che altri vengano a dar loro manforte. Quindi da un camerone, ossia da una cella a cinque posti, dovrà uscire un gruppo di prigionieri molto numeroso per bloccare le altre guardie che sono in sezione, togliere loro le chiavi, aprire i cancelli delle sezioni, aprire le celle e occupare tutto il secondo piano. Poi, rapidamente, un gruppo di compagni dovrà scendere al primo piano, sequestrare le guardie e aprire le celle di queste due sezioni dove sono rinchiusi i proletari prigionieri. A quel punto sarebbe fatta.
Facile a dirsi. Ora dobbiamo capire se si può anche fare. Si tratta di segare le sbarre del cancello del camerone dove «abito» insieme ad altri quattro compagni. Se scegliamo una domenica, all’ora di pranzo possiamo essere anche più di cinque. Da poco abbiamo ottenuto la socialità a pranzo nei giorni festivi. Ciò vuol dire che altri due detenuti possono venire a pranzare nel camerone da cinque. E siamo a sette, più i tre in rotonda siamo dieci.
Si può fare. Dobbiamo segare le sbarre del cancello. Operazione lunga e rischiosa perché può essere facilmente scoperta. Segare fa rumore e, negli speciali, il regolamento impone alle guardie di camminare su e giù per il corridoio per controllare costantemente i detenuti in cella. Camminare su e giù continuamente, lo dice il regolamento, è però faticoso; si sta più comodi nello stanzino a leggere qualche giornaletto piccante offerto da un detenuto.
Si tratta di fare quattro tagli, due per ogni sbarra da rimuovere, per ottenere lo spazio sufficiente perché i prigionieri, uno dopo l’altro, possano uscire rapidamente dal camerone per sequestrare le cinque guardie della sezione. Dobbiamo cominciare subito a segare mentre ancora non abbiamo definito i particolari dell’azione, né abbiamo ancora raccolto il consenso di tutti intorno al progetto di rivolta. Ma da fuori i seghetti non ci sono ancora arrivati. Il loro invio è complicato e non possiamo accelerarlo per il rischio di far fallire tutto, dato che dobbiamo fare ancora delle verifiche sul modo per farli entrare. Cerchiamo allora di capire se qualcuno ha già un seghetto e scopriamo che tra i «bravi ragazzi» ne hanno uno di sicuro. Ce l’ha un proletario prigioniero, un ribelle sociale, un extralegale. Si tratta di far avvicinare questo detenuto da un altro a cui non può dire di no, perché i due sono legati da un rapporto di solidarietà e amicizia molto forte, e il primo dona con piacere il suo seghetto perché sa che il dono gli tornerà utile in seguito. Il seghetto è uno strumento di cui un detenuto non si priva facilmente. Per lui può voler dire la libertà. È una privazione sofferta. Ma è pur vero che in galera se non condividi la solidarietà con gli altri prigionieri vivi male. Il seghetto arriva da una «batteria» di rapinatori provenienti dalle regioni del nord-est del paese.
Segare le sbarre – Il seghetto che si usa in carcere – contro il carcere – è un piccolo attrezzo in uso nel bricolage famigliare lungo una ventina di centimetri e alto 4-5 millimetri, ce l’hanno tutti nelle case. Essendo di acciaio è molto fragile e se viene piegato si spezza. Se lo si acquista dal ferramenta viene fornito con un archetto di ferro che lo tiene ben teso e impedisce appunto che si pieghi e si spezzi. Un seghetto si può nascondere e portarlo con sé nei vari trasferimenti per le carceri. Viene nascosto, ovviamente senza archetto, nei vari e ingegnosi sistemi di «imbosco» che i detenuti hanno escogitato nella loro storia conflittuale. Dato che l’archetto non c’è bisogna costruirlo con la plastica. Di questo materiale in carcere ce n’è in abbondanza. Si tratta di scaldare sul fornelletto pezzi di plastica e poi saldarli insieme per realizzare una sorta di archetto che tenga il seghetto ben teso. Quando la plastica brucia emette un odore nauseabondo, provoca tosse, vomito e bruciature alle dita delle mani, più qualche schizzo di plastica bollente sul viso cui si accompagna l’appello dei santi che scendono in assemblea sulla pianura pugliese. È questo il contorno necessario per produrre il sospirato archetto in grado di assolvere alla sua funzione.
Come si sega? Operazione complessa e cooperante. Uno, ginocchia a terra, impugna lo strumento per segare, ha vicino un bicchiere con l’olio d’oliva per ungere continuamente la lama del seghetto e per raffreddarla affinché possa scorrere meglio. Se disgraziatamente si incastra e si spezza siamo fritti. Per ora ne abbiamo uno solo. Accanto chi sega c’è un altro prigioniero in piedi con uno spazzolino da denti impugnato per le setole che ha attaccato all’estremità del manico una scheggia di specchio. A mo’ di periscopio il marchingegno consente di seguire i movimenti delle guardie nel corridoio e interrompere l’operazione del segare non appena si avvicinano. Il tutto viene facilitato dalle televisioni di alcune celle tenute a volume molto alto e da volenterosi chiacchieroni che impegnano le guardie con richieste impossibili per tenerle ferme di fronte a una cella molto distante dalla nostra.
Terminata l’operazione quotidiana del segare, prima di andare a dormire si deve stuccare meticolosamente il taglio fatto. Lo stucco viene prodotto in proprio utilizzando farina, bianco d’uovo, colla, e poi colorando il tutto del color dei cancelli. Intanto prosegue la preparazione dell’azione nei suoi particolari più minuti.
C’è una caratteristica che i vecchi carcerati conoscono bene: quando succede qualcosa di strano in sezione le guardie hanno l’ordine di chiudere immediatamente le porte blindate. Questione di sicurezza, ordini tassativi. Dunque le guardie nelle quattro sezioni appena sentiranno le voci concitate o vedranno la colluttazione proveranno a chiudere le porte blindate. Porte blindate che da poco avevamo ottenuto di far rimanere aperte durante il giorno, altrimenti questo tipo di azione non sarebbe stata possibile. È necessario dunque che, al momento dell’azione, in ogni cella i prigionieri inseriscano il bastone della scopa tra lo stipite e la blindata per impedirne la chiusura. Se l’azione riesce, una volta sequestrate le guardie con le chiavi in loro possesso si possono aprire tutti i cancelli delle celle. Ma le blindate no, perché le loro chiavi le guardie in servizio a quell’ora del giorno non le hanno, e quindi se qualche blindata viene chiusa è poi un problema sfondarla.
Mentre prosegue l’operazione di segare verifichiamo quanto e che tipo di materiale esplosivo abbiamo in carcere e che quantità farne arrivare da fuori e in che modo. L’esplosivo che avevamo allora nelle carceri era di un solo tipo, il plastico, il più facile da tenere addosso e portarsi negli spostamenti da un carcere all’altro. Il plastico ha la consistenza della plastilina, quella che si usa da ragazzini per sagomare i pupazzetti. È molto potente e anche abbastanza sicuro, non esplode se non con il detonatore. Puoi sbatterlo e calpestarlo, non succede nulla, persino a contatto col fuoco brucia senza esplodere. E soprattutto si può sagomare, come la plastilina, e farne delle forme che puoi mettere ovunque, proprio ovunque, anche e prevalentemente nella «cassaforte del carcerato». E ciascun detenuto rispettabile, a quel tempo, girovagava per le carceri portandone con sé dei quantitativi. Diventava quasi una parte del proprio corpo. Un etto o due di esplosivo plastico ben avvolto nella pellicola domopak non è individuabile ai più attenti controlli, anche perché non è rilevabile dal metal-detector.
Negli anni Settanta gli extralegali esperti nelle «dure» (rapine), mettendo in conto la possibilità di essere arrestati, predisponevano il proprio corpo a funzionare da contenitore di tutto ciò che avrebbe potuto essere utile in galera. Un vero e proprio kit di emergenza- arresto-evasione. Il limite di questo tipo di esplosivo è il detonatore che è di metallo (allora era di metallo), un piccolo tubo di di cinque o sei millimetri di diametro, lungo circa quattro centimetri. Questo, per detonare ha bisogno della miccia, un cordoncino di cotone trattato con polvere pirica che brucia più o meno velocemente. Il cordoncino si inserisce nel tubicino, il tubicino-detonatore si inserisce in una palla di plastico ed è fatta una bomba, molto rumorosa ma non micidiale. Basta accendere la miccia con un fiammifero o con la brace di una sigaretta, la miccia si consuma, arriva a contatto col detonatore, questo detona e fa esplodere il plastico. Non provoca danni alle persone se il plastico è lasciato libero, poiché l’esplosione non produce schegge, provoca soltanto un grosso botto con relativo spostamento d’aria. Se invece questo fagottino si inserisce in un contenitore metallico, che so, una macchinetta del caffè moka, questa si spezza in più parti che vengono scagliate violentemente a raggiera, schegge che possono ferire.
Ce n’era dunque di plastico in giro tra i detenuti, ma non in misura sufficiente a garantire una difesa delle sezioni occupate di fronte al prevedibile assalto di guardie e carabinieri.
Farne arrivare ancora non era un gran problema, per le sue caratteristiche si nasconde ovunque. Dopo diverse verifiche constatiamo che i contenitori termici riescono a passare. Questi hanno una intercapedine di materiale coibente per impedire la dispersione della temperatura, calda o fredda, del suo contenuto. Il materiale coibente si può sostituire con del plastico. Così chiediamo un contenitore con dentro del cibo e, nell’intercapedine, del plastico.
Il problema sono i detonatori, che sono di metallo come i seghetti. Non c’era altro modo se non… la piccola e famosa «lettera 22» che ci consentivano di far entrare per farci scrivere, scrivere, così i loro esperti potevano leggere, leggere quello che scrivevamo. Una macchina da scrivere serve per scrivere, certo, ma può essere utile per tante altre cose. Facciamo delle verifiche su che tipo di controlli operano prima di consegnarcela. Ce ne facciamo inviare una «pulita» e constatiamo che il rullo, sul quale poggia e scorre la carta, non viene smontato, anche perché è operazione non agevole.
Il rullo è un tubo di ferro ricoperto da un tubo di gomma. Chiediamo ai compagni esterni di inserire nel rullo un certo quantitativo di seghetti e di detonatori. Le operazioni di verifica vanno per le lunghe e anche quelle di spedizione, la macchina con la fornitura arriva solo un paio di giorni prima della data fissata per l’azione.
Questo ritardo ci preoccupa al punto che pensiamo di spostare la data dell’azione, ma le festività natalizie sono le più propizie per la rivolta come l’abbiamo congegnata.
L’operazione di segare le sbarre del cancello è andata bene, siamo quasi al termine. È stato sufficiente un solo seghetto, ma non possiamo tenere una cella con il cancello segato troppo a lungo. Benché stuccate a dovere le due sbarre sono comunque segate e, a ogni sbattuta di cancello, il cuore ci sobbalza. Se si staccano e cascano? Probabile, dato che le guardie hanno l’abitudine di sbattere i cancelli con violenza per chiuderli. A volte, nel rientrare, l’ultimo di noi accompagna il suo rientro chiudendosi appresso il cancello, come si fa nella vita civile, accompagnandolo dolcemente.
Ma in carcere questa cosa non si fa mai, per principio, infatti ti dicono: «E che fai, ti chiudi da solo?». Chiudere il cancello da sé è un modo di fare dei carcerati che hanno rotto qualsiasi rapporto con la comunità prigioniera, è un voler sottolineare il proprio isolamento. Questo comportamento è un segno premonitore «scoppiatura» imminente. Ma di noi chi sospettava che stessimo per «scoppiare»? Le guardie restano esterrefatte per questi nostri comportamenti incomprensibili. Siamo tutti teatranti.
Oltre a chiuderci il cancello da soli mettiamo in atto una serie di comportamenti tali da sembrare, di fronte alle guardie, totalmente rimbecilliti. Sotto le feste di natale prepariamo pranzi sontuosi, inviti a pranzo, torte comprate alla spesa o realizzate da noi. Vedendoci così le guardie pensano che il carcere sia diventato il nostro ambiente di piacevole convivenza. Fissiamo la data della rivolta per l’ultima domenica dell’anno, il 28 dicembre, inventandoci che è un qualche anniversario da festeggiare nel nostro camerone con ospiti e tavola imbandita.
Operazione tatzebao – Qualche passo indietro. Appena decisa la rivolta inizia l’«operazione tatzebao». Chi non conosce questa parola? Tra le più usate negli anni che vanno dalla seconda metà del decennio Sessanta a tutto il decennio Settanta nelle città cinesi, europee, nord americane e asiatiche. Il tatzebao non è altro che un manifesto con scritte a grandi caratteri. Il nome, in lingua cinese, pare voglia dire appunto: manifesto a grandi caratteri.
Questi manifesti sono stati usati tantissimo nelle università, nelle scuole, nelle fabbriche, nei quartieri, negli anni della grande comunicazione orizzontale di massa. Con i tatzebao si annunciano riunioni o assemblee, si denunciano soprusi, si segnalano lamentele, oppure si fa propaganda, cioè si dà la versione di un avvenimento secondo un particolare punto di vista politico, sociale oppure ideologico.
Ma nelle carceri non si erano mai visti. Potenza dell’auto-convincimento. Quando ti convinci che non è vero che ti hanno beccato e che resterai in quella gabbia per lunghissimo tempo, forse tutta la vita, ma che il carcere è un luogo come un altro, come il quartiere, come la fabbrica, solo con qualche sbarra in più, e che l’attività politica che facevi fuori la puoi fare anche qui dentro, ebbene, quando sei tanto folle da convincerti di questa cosa ti metti a usare con stravaganza gli stessi strumenti di propaganda che usavi fuori.
E così nasce il tatzebao in carcere. Il motivo è più umano che politico, lì dentro vuoi essere vivo, pensarti vivo, comunque vuoi un buon antidoto alla morte lenta somministrata dalla galera. Così, passata la conta delle 11.00 di sera, ci mettiamo sul tavolo, pennarelli, lametta e colla, come una scolaresca elementare. Non ci sono i fogli grandi, niente paura. Si prendono i fogli del consueto formato A4, quelli che si usano per la macchina da scrivere, e si attaccano con la colla fatta con la farina. Con otto fogli si fa un manifesto di circa 60 centimetri per 80. Per scriverci sopra ci sono i pennarelli che molti usano per disegnare o dipingere.
La composizione di questi tatzebao viene fatta ritagliando i titoli dei giornali e commentandoli con grandi scritte usando i pennarelli di vario colore. Il contenuto è la condizione nelle carceri speciali in rapporto al sequestro del dirigente dell’amministrazione penitenziaria compiuto dall’organizzazione. I ragionamenti vengono fatti come se un detenuto non politicizzato stesse osservando quello che avviene: finalmente i giornali parlano di carcere. I responsabili del governo costretti a parlare delle carceri speciali e della loro invivibilità. Ciascun esponente di partito dice la sua e questo ci permette di mettere in luce i contrasti tra loro, le ragioni di questi contrasti e le incongruenze del loro parlare. Intervengono magistrati e avvocati.
Nei giorni del sequestro tutti parlano di carcere, bene, parliamone pure noi, facciamo sentire la nostra voce. Dati fino ad allora taciuti vengono resi noti e mettono in luce le condizioni disumane cui vengono costretti i detenuti in alcuni «speciali», si parla dell’Asinara, si parla di Faina che sta morendo in carcere. Con i pennarelli colorati mettiamo in risalto la brutalità del regime che a parole si dice democratico ma agisce al pari di quello fascista. E così via via, fino a rendere partecipi e attivi alla vicenda del sequestro quei prigionieri che, anche se tombati in quel buco di merda, divengono consapevoli di poter determinare alcune scelte dei potenti.
Giorno dopo giorno la gran parte dei prigionieri si identifica, o comunque si trova d’accordo, con gli obiettivi del sequestro: liberazione e guerra alla differenziazione, chiusura delle carceri speciali.
La lunga pratica con questo tipo di propaganda, il tatzebao, ci permette una certa destrezza nel produrre questi fogli di comunicazione. Ne facciamo quattro copie perché quattro sono i cortili dei passeggi e, con alcuni accorgimenti, vengono scambiati tra cortili. Non sono copie perché ognuno è diverso dall’altro. Si finisce il lavoro a notte fonda. La mattina, quattro della nostra cella scendono all’aria ciascuno con il suo foglio ben ripiegato e infilato tra la schiena e la maglietta. Nel corridoio dei passeggi se ne lascia uno per ogni cortile, e mani di volta in volta diverse lo raccolgono e velocemente lo attaccano bene in vista sul muro con il nastro adesivo o con la gomma da masticare. Passata una mezz’ora i detenuti, dopo averlo letto e commentato, staccano il manifesto, lo piegano, lo mettono in una busta di plastica insieme a una ciabatta per dar peso all’involucro e lo lanciano al di là del muro divisorio con l’altro cortile. In questo modo ciascun cortile legge i quattro tatzebao.
Inizialmente le guardie, vedendo questi fogli di carta attaccati ai cortili e il traffico per scambiarseli, restano esterrefatti. Chiedono ai detenuti di consegnarglieli, cosa che i detenuti si guardano bene dal fare. Le guardie non possono entrare a prenderli perché dovrebbero chiamare rinforzi: tre guardie non entrano in un cortile dove ci sono una ventina di detenuti «speciali», cioè pericolosi. Finita l’ora d’aria, i manifesti scompaiono tra i vestiti dei detenuti e ricompaiono all’aria del pomeriggio, per la lettura di chi aveva saltato l’aria della mattina. Poi di nuovo scompaiono per andare in qualche cella di chi forse se li vuole studiare attentamente. Non ho mai saputo chi li collezionasse. C’era un ragazzo di Catania che «lavorava» a Milano. Non era mafioso ed era dovuto fuggire da Catania perché la mafia lo cercava per furti nei negozi «protetti».
Ogni mattina quando arrivava al cortile chiedeva insistentemente: «Arrivò ’o zibao?». Era molto interessato a leggerlo. Un fatto nuovo, in un ambiente come il carcere fatto apposta per uccidere ogni creatività e novità, produce grande discussione.
Questo vogliamo ottenere. Bene, la propaganda sortisce i suoi effetti. Ormai tutti sono molto attenti all’andamento del sequestro del funzionario del Ministero e a quello che dice l’organizzazione nei suoi comunicati, ma soprattutto si comincia a parlare di come fare la nostra parte perché la lotta alla differenziazione, ossia la fine degli «speciali», si avvicini.
Per i «banditi» il rientro nel circuito normale è una necessità impellente. Loro, a contatto con la gran massa dei detenuti, intessono relazioni, prendono contatti, costruiscono aggregati, insomma portano avanti la loro «professione», e poi, dalle carceri «normali» è più facile evadere.
I cacadubbi – Nel gergo carcerario questa parola identifica chi non essendo d’accordo con quanto si sta preparando, invece di dire no, non sono d’accordo, oppure, non me la sento di fare questa cosa, solleva un’infinità di dubbi, per lo più campati in aria, secondo i quali la cosa progettata non potrebbe riuscire. I cacadubbi non danno una mano a correggere eventuali difetti e far sì che l’iniziativa riesca al meglio, ma intralciano soltanto il lavoro mettendo i bastoni tra le ruote a ogni iniziativa.
Quando in carcere ho sentito questa parola l’ho subito usata per definire quelli che nel movimento alcuni anni prima sollevavano gli stessi dubbi sconclusionati nei confronti di qualsiasi iniziativa si volesse fare. L’anno di maggior diffusione di questa «specie umana» è stato il ’77. Me li ricordo benissimo, uno per uno, perché non erano tanti, uno in più della decina34, ma rompevano, eccome rompevano. Non c’era iniziativa appena energica che non trovasse i suoi detrattori. Dicevano: e se facciamo così offriamo il fianco all’accusa di essere provocatori, e così ci perdiamo il consenso, e così non ci capiscono, e se facciamo questo aumenta la repressione.
Sia che si volessero prendere delle automobili e metterle in mezzo alla strada per fare barricate e fermare le cariche dei pulotti, sia che si volesse ragionare di azioni di attacco, apriti cielo, grandinavano i dubbi. Affermavano, i cacadubbi con serietà, di non essere contro l’uso della forza e la violenza, però che questa si può usare solo e quando le masse sono totalmente d’accordo, solo quando le masse possono totalmente comprenderlo. Insomma, era una giaculatoria di dubbi, recitati in maniera scaramantica, sperando che non si facesse nulla.
Qui in carcere, quando si comincia a diffondere la voce che probabilmente si farà qualcosa per manifestare la volontà di abolire le carceri speciali, chiudere l’Asinara e farla finita con la differenziazione i più accorti si rendono conto che una cosa del genere assomiglierà molto a una rivolta. La voce gira, e noi la lasciamo girare. È una specie di sondaggio.
Ed ecco i cacadubbi manifestarsi. Non provengono solo da quelli che hanno poca galera da fare, oppure quelli che devono ancora subire il processo e sperano di essere assolti. Questa ritrosia, da parte di chi ha tale situazione giuridica, è del tutto legittima e comprensibile, infatti la partecipazione a una rivolta nel curriculum di chi va davanti al giudice non depone a favore dell’innocenza. Però i cacadubbi non usano queste argomentazioni, che sarebbero di tutto rispetto. Ci sono anche degli accorgimenti per andare incontro a esigenze di questo tipo, come chiedere un avvicinamento alla famiglia di un mese per un parente malato. Se te lo concedono te ne stai un mese lontano dai tumulti. Al Ministero interessa, per tenere il prigioniero isolato e studiarlo meglio. Poi ci sono tante altre scappatoie. Ad esempio, tra gli assidui frequentatori di galere, quelli con condanne lunghe, c’era l’abitudine che quando capitavi in un carcere non speciale per un processo o un appoggio nel corso di un trasferimento, ti prendevi una denuncia, che so insultando una guardia e rompendo qualcosa dell’arredo. Queste denunce prima o poi arrivano in Tribunale e tu hai (avevi) il diritto di presenziare al processo, se vuoi puoi quindi spostarti dallo «speciale» dove sei rinchiuso per andare in quel Tribunale, e la data la conosci qualche mese prima. Se non ti serve quel trasferimento rifiuti di presenziare, se ti torna utile ci vai. Infine c’è la soluzione infermeria. Se accusi un malore importante vieni trasferito in infermeria per alcuni giorni, e l’infermeria è lontana dalle sezioni speciali. A far salire la febbre «a quaranta» sono capaci le reclute dell’esercito per schivare servizi pericolosi, figuratevi se il sapere carcerario non sa farlo.
Ma alcuni, per non sembrare egoisti o fifoni, la buttano in politica. Non è il momento, dicono, il governo non aspetta altro per aumentare la repressione ecc. Altri usano argomenti più interessanti, dicono che è meglio aspettare e preparare un’evasione. Fosse facile. Oppure, dicono, è meglio aspettare per preparare tutti insieme con gli altri detenuti di tutte le carceri speciali una serie di rivolte.
Che timori ci siano, lo si sente filtrare qua e là, ma c’è anche la voglia di farsi sentire, di esistere, di non volerci stare nel ruolo dei sepolti vivi nelle versione soft o in quella dura. Il discorso che convince e scaccia ogni dubbio è che la differenziazione anche all’interno delle carceri speciali è un pericolo incombente per tutti. Oggi siamo qui a Trani, dove qualche spazio c’è, ma basta che fai una cazzata e, da un momento all’altro, ti «fai la roba» (metti in un sacco i tuoi indumenti e le tue cose per un trasferimento) e ti «sballano» all’Asinara o a Nuoro, e lì sono dolori veri. Quasi tutti i prigionieri hanno un amico o un conoscente dentro quell’inferno e non ce lo vogliono lasciare. È proprio questa la parola chiave usata nei tatzebao che apre i cuori alla disponibilità alla rivolta: chiediamo la chiusura dell’Asinara. Nuoro era chiuso per lavori di ristrutturazione dopo una rivolta di qualche mese prima.
A questo punto i cacadubbi sono diventati oggetto di dileggio: «Buttati alle celle!» (vai volontario alle celle di isolamento per non essere coinvolto dalla rivolta), veniva loro detto nelle interminabili discussioni all’aria.
[dal Capitolo 19]
Si va! – Domani è la giornata tanto attesa… Difficile dormire questa notte. I pensieri si rincorrono, non ce la fai a scacciarli. Nostalgia per gli anni trascorsi? No, non è nostalgia quando hai cercato di fare quello che pensavi giusto fare. Casomai affiora rammarico per non aver capito in tempo questa o quella cosa. Inadeguatezza, forse, ma non nostalgia. Questa disegna lo stato d’animo di chi vive col rimpianto di non aver fatto quello che voleva o poteva. Noi l’opportunità l’abbiamo colta. Abbiamo fatto quello che ritenevamo di dover fare. Avremo potuto far meglio e di più, certamente. C’è comunque l’interesse a tornare criticamente a ciò che in quel tempo e in quello spazio si è fatto nei tanti e diversi modi dell’agire rivoluzionario. La volontà c’è ma non ci sono le condizioni, si dice. O forse la volontà non è così forte da creare le condizioni.
Le 8.00 del mattino – È domenica 28 dicembre dell’80, sono le 8.00 del mattino. I dubbi e le domande occupano il tavolo dove zampilla il caffè. Siamo tesi come corde di chitarra. Ci accingiamo a far colazione, sentiamo il giornale radio. Sembra tutto a posto. Il giorno prima, sabato, c’era stata la perquisizione generale. È quel tipo di «perquisa» dove ti svegliano alle 5.00 della mattina. Ti piombano in cella dieci guardie, due a fianco di ogni branda e ti devi alzare, insonnolito, davanti a loro. Perquisizione integrale, ossia nudo, poi tutti in corridoio e, dopo un’altra perquisizione, nella sala della socialità. Un camerone grande circa il doppio della cella da cinque posti. Ce l’aspettavamo e quindi tutto era stato predisposto. La «perquisa» era andata a pennello. Durante la sera del sabato avevamo tirato fuori dai nascondigli il materiale necessario per la rivolta, serviva il giorno dopo e ormai eravamo tranquilli poiché la «perquisa» c’era già stata in mattinata.
Il materiale, l’esplosivo e i detonatori, li avevamo a portata di mano, ossia nelle mutande.
Dopo la conta del mattino, col caffè in una mano e la sigaretta nell’altra, qualcuno al cesso, aspettiamo l’ora dell’aria. Improvvisamente sentiamo uno scalpiccio di passi, troppi passi. Che succede?
L’istinto carcerario reagisce, il materiale sparisce nelle pieghe del corpo… è una «perquisa». Strana per l’orario, sono le 8.00 passate, strana perché l’avevano fatta il giorno prima. Quando le guardie entrano P. ha una grande intuizione, prende a protestare per il fatto che la «perquisa» generale era stata fatta il giorno prima, non si fidavano dei loro colleghi? Che pensavano di trovare? Ci rovinavano anche la festa che stavamo preparando… le torte sul tavolo in bella vista stavano lì a testimoniarlo. Le guardie rimangono anche loro interdette, il fatto non ha spiegazione nemmeno per loro, non sanno il motivo di quella reiterata «perquisa », a loro non viene detto nulla, obbedire e zitti. Questa è una loro debolezza, ma l’apparato militare dello Stato ha queste regole. Incalzati dalle argomentazioni di P. cui C. dà man forte, fanno la perquisizione personale in fretta e senza convinzione. E noi usciamo dalla cella ingrugnati, come se ci avessero fatto un torto. Usciamo con tanta di quella roba addosso… e ci infiliamo rapidamente nel camerone della socialità.
Qualcosa di strano – Sudore freddo. Il materiale è salvo, ma ci sono le sbarre del cancello. E sentiamo battere pesantemente proprio le sbarre. Addio, è fatta. Ci sarà stata una «soffiata» (spiata) o una «smarronata» (lasciarsi sfuggire, per disattenzione, qualche informazione che le guardie non dovrebbero sapere). Se scoprono il cancello con le sbarre segate gli occupanti di quel camerone vengono portati alle celle di isolamento per punizione. È questa la prassi. Allora bisogna immediatamente scambiarci il materiale. Noi della cella «segata » non dobbiamo avere nulla addosso perché verremo rivoltati come un calzino. Detto fatto. Poi ci sarà da gestire la mancata rivolta.
Si butta giù a mente la bozza di un volantino nel quale si dice tutto, come se la rivolta fosse stata fatta, si rivendica la volontà e il diritto dei detenuti di ribellarsi di fronte alla strategia dell’annientamento, della differenziazione, l’isolamento e bla bla bla. Qualcuno dovrà occuparsi anche di avvertire i familiari di quelli «puniti» ai quali verrà vietato per lungo tempo il colloquio. E si sente battere… Abbiamo pensato a tutto? Qualcuno abbozza un abbraccio a noi che siamo destinati alle celle di isolamento. Poi, gradualmente, i rumori diminuiscono di intensità, si sono fatte le 9.00.
Aprono il camerone e cominciano a chiamare per numero di cella. Gli occupanti della cella nominata debbono recarsi sul cancello, essere di nuovo perquisiti e rientrare nella loro cella. Noi abbiamo le facce tirate, invece le guardie sembrano calme. Strano, se avessero trovato un cancello segato sarebbero agitati. Arriva il numero della nostra cella. Esco per primo con le gambe che sembrano quelle di un ubriaco, per nascondere la tensione sbadiglio in faccia a una guardia. Nel corridoio camminando cerco di sbirciare il cancello, non vedo bene, ho gli occhi appannati. Cosa non ti fa la tensione. O santa citrulla, il cancello è intatto. È aperto e si vede bene, tenuto con una mano da una guardia che lo apre al tuo passaggio e poi lo accosta. Le sbarre segate stanno lì al loro posto. Mi esce tutta l’aria che avevo compressa nel ventre in un respiro liberatorio e passo sorridendo in faccia alla guardia, l’avrei abbracciata. In cella c’è stato un terremoto. Tutto sfasciato. Buchi nei muri, lavandino quasi divelto, brande ribaltate, zucchero sparso ovunque, il sale insieme al caffè. Le torte affettate rozzamente ma ancora mangiabili. Hanno trovato soltanto un vecchio e arrugginito punteruolo, inservibile, che stava imboscato lì da anni. Ma nient’altro. Abbiamo tutto addosso.
Le guardie escono dalla sezione e noi ci abbracciamo dalla contentezza. Ma che avranno battuto? Le sbarre della finestra, naturalmente. Dalla cella si esce dalla finestra, non certo dalla porta per ritrovarsi nel corridoio, in un posto ancora più chiuso. Al cancello non ci avevano proprio pensato. Il limite delle guardie è di essere guardie. Meglio così. Riprende con ritardo il normale svolgimento della vita carceraria. Arriva l’ora d’aria e ci si va tutti per raccontarci dello scampato pericolo e per riordinare le cose da fare. Ormai mancano poche ore…
Ci siamo – Rientrati dall’aria della mattina ci prepariamo per il pranzo. Ma prima di rientrare facciamo anche noi una specie di conta, domandiamo a ciascuno se vuole scendere all’aria il pomeriggio. È indispensabile che al passeggio pomeridiano il numero sia dispari, in modo che alla fine del rientro ne rimangano tre. Ripetiamo più volte la domanda pregando ciascuno di essere sicuro di quello che intende fare e alla fine riusciamo ad avere il numero dispari. In cella cominciamo a imbandire la tavola con pietanze elaborate, torte e tutto quello che faccia pensare a una festa. L’altra tavola, nel cesso, la imbandiamo invece con gli attrezzi necessari alla rivolta. Mettiamo il tavolo dove si pranza ben in vista davanti al cancello, in modo che le guardie vedano gente intenta a rimpinzarsi e non altro. Arrivano i due ospiti. Diossina e Massimino. Sono loro che dovranno mettersi nel cesso a preparare il plastico con il detonatore e la miccia, sia in carica libera, sia dentro la moka. Noi cinque restiamo ben in vista intorno al tavolo intenti a banchettare, per tranquillizzare le guardie. All’aria del pomeriggio, con la scusa del pranzo festaiolo del nostro camerone non scende nessuno. In realtà ci prepariamo all’uscita dalla cella appena scatterà l’azione in rotonda. Sta andando tutto bene. A un certo punto Massimino esce dal cesso con i capelli dritti: «Qui saltiamo tutti per aria» dice con voce soffocata, «c’è Diossina che sta maneggiando i detonatori in maniera poco ortodossa ». Vado a vedere e in effetti Massimino ha ragione: «Attento Diossina, qui saltiamo noi, altro che rivolta». «Non ti preoccupare» mi dice col suo accento veneto contaminato da altre inflessioni. La buona stella ci assiste, il lavoro è finito. Siamo tutti intorno alla tavola. Una tavola ben strana. Verso il cancello, quindi ben visibile alle guardie, cibo torte, insalatiere di plastica. Dalla nostra parte, a fianco delle posate di plastica, non visibili dall’esterno, ci sono i punteruoli e le cariche esplosive che ciascuno prenderà prima di precipitarsi fuori dal cancello. Siamo prossimi alle 15.00 del pomeriggio, l’ora del rientro dall’aria. P. si mette vicino al cancello con espressione sorridente. Cominciano a salire i primi. Passando davanti alla nostra cella qualcuno ci saluta con allegria per tranquillizzare le guardie, altri passano con una faccia scura su cui sembrano calate improvvisamente tutte le preoccupazioni del mondo.
Occupiamo la sezione – Le 15.15. Sono passati quasi tutti, siamo in attesa. Con una mano D. prende la barra segata per strapparla appena sente il segnale, l’altra la farà saltare con un calcio. Un urlo, partiamo. Un attimo e siamo nel corridoio. Le guardie sono girate verso la rotonda a guardare la breve colluttazione in corso tra i compagni e loro colleghi. Gli intimiamo di arrendersi. Forse la confusione, più che la volontà di opporsi al sequestro, genera una breve zuffa nella quale una agente rimane lievemente ferito. Niente di grave, un graffio. Adesso dobbiamo agire con rapidità, come avevamo predisposto. Alcuni di noi tengono ferme le guardie e gli tolgono le chiavi, chiavi che avrebbero potuto gettare solo nella rotonda già da noi occupata. Per questo motivo avevamo deciso di far partire l’azione proprio dalla rotonda, altrimenti avremmo avuto un punto debole. Un compagno prende le chiavi delle celle di tutta la sezione e le apre. Con quelli che escono si formano due gruppi. Un gruppo si reca alla sezione di fronte e l’altro scende al primo piano. La tecnica è la stessa. Ciascun gruppo si reca davanti al cancello delle sezioni del primo piano e a quella del secondo facendo vedere la carica esplosiva, chiede di aprire il cancello altrimenti verrà gettata all’interno del corridoio la macchinetta del caffè esplodente, spiegando bene il danno che potrà fare loro. Urla, parole concitate e alla fine ci aprono. Di guardie ne abbiamo «arrestate» 13 al secondo piano e 5 al primo. In totale 18 agenti, un record.
Altra azione urgente: un gruppo si deve portare verso il piano terra dove le scale sbucano nella rotonda, da lì potrebbero arrivare i rinforzi delle guardie per riprendere in mano le sezioni. Sono muniti di cariche esplosive e alcune bottiglie riempite con il gas delle bombolette del fornelletto. Le bottiglie sono chiuse ermeticamente con il tappo e la cera, e intorno alla bottiglia è annodato uno straccio. Si dà fuoco allo straccio e si lancia la bottiglia, questa si rompe, il gas liquido esce e a contatto con la fiamma dello straccio produce una fiammata di brevissima durata ma molto intensa.
Una sorta di bottiglia molotov, ma molto meno efficace. Appena in tempo, non sono passati che venti minuti ed eccoli. Sono i rinforzi delle guardie e sono in tanti. Corrono verso le scale, attraversano la rotonda del piano terra, stanno per imboccare i gradini, quand’ecco che, sulla prima rampa di scale arriva una carica di esplosivo e… boom! È una «carica libera» per non ferire nessuno, accompagnata da una «molotov al gas». Gli spazi delle scale sono stretti, l’esplosione è forte e anche il rumore. Nessuno si fa male ma si spaventano, girano velocemente sui tacchi e tornano indietro. Ora possiamo barricare il cancello del piano terra da cui si accede all’androne delle scale dove siamo noi.
Per ora è andato tutto bene. Un miracolo che abbia funzionato tutto, fin qui. Per gli umani l’organizzazione è l’eccezione, la regola è il caos, ed è quanto succede nelle ore successive.
Ancora una cosa da fare, andare a parlare con i detenuti comuni del primo piano. Non vorremmo che durante la rivolta avvengano regolamenti di conti tra di loro. Ne verrebbe inquinato il significato della rivolta. Poche frasi, strette di mano, la parola è data, sono ragazzi perlopiù del nord italia, genovesi, bergamaschi, milanesi, veneti, e alcuni rapinatori catanesi non mafiosi. I mafiosi allora non stavano nelle carceri speciali, i governi di quegli anni e gli organi dello Stato chiudevano un occhio, anche due, verso la mafia, sia per intrallazzi economici e sia per riceverne un aiuto per stabilizzare il paese «in mano ai sovversivi». Infatti la mafia, si sa, odia i sovversivi e ama la stabilità sociale.
Nulla di spiacevole avviene dalla parte dei proletari prigionieri, la loro parola vale. Invece un guaio succede al secondo piano nella sezione di fronte a quella dove ci troviamo. La poca attenzione dei compagni di un camerone aveva permesso alle guardie di chiudere la porta blindata della loro cella. Ci sono volute tre ore di lavoro faticosissimo per sfondare quella porta blindata usando come ariete un’altra divelta dai cardini.
Venticinque ore di libertà – Nelle prime due ore tutto funziona bene, oltre ogni più rosea previsione. Quasi tutto. Alcuni compagni erano stati incaricati di ungere ben bene le scale di grasso e olio lasciando solo una ventina di centimetri non unti per passarci noi. Nell’eventualità di un attacco avrebbe rallentato la carica dei militi provocando scivoloni. Dimenticato. Si svolgono i compiti predisposti. Portiamo tutte le 18 guardie sequestrate al secondo piano, in alcune celle. I ruoli si ribaltano e alcuni detenuti fanno la guardia alle guardie. Le guardie ora vestono tute ginniche come noi, vanno controllate a vista per diversi motivi. Per evitare che qualche testa calda, tra i prigionieri, colga l’occasione per vendicarsi di qualche torto subito e per evitare che facciano dalle finestre segnali ai loro colleghi sul muro di cinta. Intanto le finestre vengono chiuse con dei materassi per evitare che dall’esterno possano sparare dei candelotti lacrimogeni dentro le sezioni.
Nel piccolo ufficio della custodia al secondo piano, dove è istallato il telefono, insediamo un gruppo di compagni e detenuti con in testa Giuliano, che sarà il «telefonista» per i contatti esterni. Per tutto il tempo della rivolta quel telefono rimarrà l’unico contatto con la direzione e l’esterno. Quella piccola stanza funziona come una sorta di «ufficio relazioni esterne». Dall’altra parte del telefono infatti c’è la direzione del carcere ma, data la situazione, anche funzionari del Ministero, del governo e dei comandi dei carabinieri.
Tutti questi personaggi, il giorno dopo, li vedremo aggirarsi sul muro di cinta per predisporre quello che poteva diventare una grande mattanza.
In quella stanza doveva avvenire una sorta di consultazione permanente tra i diversi gruppi addetti ai vari compiti per coordinarsi e decidere il da farsi di fronte a fatti nuovi. Una volta riuscita la rivolta, la sua gestione era in mano al Comitato di lotta, un organismo formato da compagni e proletari prigionieri che si erano assunti la responsabilità della preparazione e gestione della rivolta.
Quella piccola stanza diventò invece il punto più affollato e rumoroso di tutto il carcere. Erano sempre tutti lì per conoscere le informazioni che venivano da fuori. Sembrava un bar dello sport durante una partita di pallone.
Dopo l’occupazione delle sezioni la direzione aveva staccato la luce e l’acqua. Nel primo contatto telefonico chiediamo il ripristino dell’erogazione dell’una e dell’altra. In cambio la direzione vuole parlare con le guardie sequestrate per accertarsi delle loro condizioni di salute. Accordato. Le guardie dicono con enfasi che stanno tutte bene, che vengono trattate bene, ma che ce n’è una ferita leggermente. Noi chiediamo al direttore di prendersi la guardia ferita per portarla in ospedale. Qui succede il primo fatto strano.
La direzione prima dice di sì, poi, una mezzora dopo, su evidenti pressioni esterne, dice di no. Uno strano comportamento.
Secondo il buon senso, se obiettivo della direzione era quello di far andare tutto liscio, la prima cosa da fare era riprendersi la guardia leggermente ferita. Ma la direzione non contava più nulla. Noi parlavamo col direttore ma le parole non erano le sue, lo si capiva anche dal tono della voce. La strategia del Ministero, o di chi aveva preso in mano le redini decisionali della gestione della rivolta sull’altro versante, era di predisporre il terreno a una soluzione militare durissima.
Se ne rendono conto per primi gli agenti sequestrati guardando la televisione in cella: le notizie che danno i tg sono tutte false e tendono a diffondere il sospetto che vi siano feriti gravi tra le guardie, che vengano tenute in condizioni disumane e che le stiamo per ammazzarle tutte.
Ci chiamano e ci dicono preoccupati che quelle falsità le stanno dicendo tutti i tg, sia quelli nazionali che quelli locali. Si tratta evidentemente di una velina del governo. Ci chiedono di poter telefonare alle proprie famiglie per rassicurarle sul loro buon stato. Giuliano ci mette tutta la sua capacità di persuasione per convincere il direttore che non c’è niente contro la sicurezza nel far parlare alcune guardie con le loro famiglie, per rassicurarle. Il direttore dice di portare le guardie al telefono, lui farà venire i famigliari.
I primi due agenti arrivano davanti al telefono. Uno parla col direttore, è speranzoso di sentire dall’altro capo la voce della moglie. Ma si gira verso di noi e, buio in faccia, ci restituisce la cornetta farfugliando che il direttore non può. Cerchiamo di farci Dare spiegazione ma il direttore ci dice che quelli sono gli ordini.
La cosa è strana. Chi si incazza di più sono gli agenti: da noi hanno il permesso, il direttore o chi per lui glielo nega.
Cerchiamo di capire: probabilmente il governo, i carabinieri, stanno cercando di gestire la rivolta come se dei mostri disumani, noi, stessero sbranando dei poveri agenti, questo per preparare l’opinione pubblica a un attacco militare duro che può lasciare sul terreno anche qualche morto, anche un massacro. Ci ricordiamo di Attica, negli Stati Uniti: una trentina di morti durante una rivolta per schiacciare il movimento delle pantere nere molto radicate nei penitenziari statunitensi. Quella scelta probabilmente è stata imposta dalle alte sfere del potere, si vuole un massacro per stroncare sul nascere la ripresa di un ciclo di rivolte. In campana ragazzi. Che altro possiamo fare se non gestire nel modo più tranquillo e ordinato la faccenda? Cerchiamo di tenere attivo il contatto telefonico con la direzione. Arrivano anche dei parlamentari, sottosegretari, consiglieri regionali, avvocati, ma si capisce che tutti questi vengono a dire parole inutili, vuote. In fondo le nostre richieste sono semplici e possibili. Non chiediamo certo di andare a casa. Sappiamo che non sarebbe possibile.
Obiettivi possibili – Questo non è un film americano dove dei galeotti sequestrano delle guardie e chiedono un elicottero o una macchina per andarsene dall’altra parte del mondo. Noi puntiamo a richieste molto semplici, quasi banali, perché il punto è costringere il potere a cedere.
Anche di un’unghia, ma cedere. Infatti, nel comunicato che consegniamo alle 17.00 del pomeriggio, dopo una sequela di frasi politiche contro il carcere e la differenziazione, chiediamo semplicemente la chiusura dell’Asinara, carcere diventato ormai inaccettabile anche per il «mondo democratico». Pronunciamenti e polemiche si sono susseguite all’interno dei partiti e della magistratura per chiudere la sezione speciale di quell’assurda galera. Inoltre, chiediamo la liberazione di Gianfranco Faina, gravemente malato. In quegli anni la protervia del potere era giunta a livelli parossistici. Come l’accanirsi contro Faina, la cui sorte era segnata, costringendolo a morire in carcere, come l’aver costretto alla morte Alberto Buonoconto.
Eppure in quegli anni era la norma. Grazie alla rivolta Gianfranco passò gli ultimi mesi di vita nel suo letto tra le persone che aveva piacere che lo accudissero. L’8 gennaio, una settimana dopo aver massacrato i rivoltosi, la procura di Firenze gli concesse la libertà provvisoria. Due mesi dopo morì nella sua casa di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Che la terra ti sia lieve, Gianfranco.
L’ultima richiesta era semplicemente far pubblicare da giornali e tv il nostro comunicato. Si trattava di richieste possibili e legittime, in fondo chiedevamo al governo di rispettare le sue stesse leggi nei nostri confronti. Era una sfida e, posta in questi termini, ai governi e alle istituzioni dava fastidio. Nessun governo o parlamento riconoscerà mai di non aver applicato la sua legge. Anche se molto spesso non l’applica per motivi di ordine e sicurezza.
In Italia, in quegli anni, i motivi avevano preso il nome di emergenza. E da quegli anni diventò un sistema di governo. Tutto si poteva fare in nome dell’emergenza. Il testimonial di quella «nouvelle vague» fu Francesco Cossiga, ben appoggiato, oltre che dal suo partito democristiano, anche dal Pci, dai repubblicani e dal giornale «la Repubblica». Quei governi dalla metà degli anni Settanta in poi – alcuni di «unità nazionale», altri non più – vararono tali e tante di quelle norme eccezionali, appunto emergenziali, da far invidia al pacchetto antiterrorismo di un quarto di secolo più tardi di Bush, il Patriot Act del 2001, varato dopo l’attentato alle Torri Gemelle. Le leggi italiane emergenziali erano in contraddizione con alcuni dettami della Costituzione, ma ciò non produsse, tranne rare eccezioni, grandi turbamenti nel corpo della magistratura e dei tutori del diritto.
Il caos – Gli effetti sui detenuti prodotti da quella specie di libertà sono strabilianti. Quel piccolo spazio liberato diventa il luogo dove si scatena la fantasia e la creatività di chi non ha più catene. Dopo le prime ore in cui il muoversi dei detenuti appare relativamente ordinato la situazione diventa caotica. Come se a certo punto tutti ci fossimo messi d’accordo nell’impegnarci in attività completamente senza senso. Ciascuno si veste, o meglio, si maschera a modo suo, chi mette un fazzoletto sulla la faccia, chi rompe un tavolino per ricavarne una gamba da impugnare a mo’ di bastone. Alcuni addirittura costruiscono dei rudimentali scudi.
Un atteggiamento consueto nelle manifestazioni di piazza di quegli anni ma insensato perché inutile in carcere. Non certo uno scontro di piazza avremmo avuto di lì a poco. E questo lo sapevamo tutti. Se attacco ci sarebbe stato non si sarebbero di certo usati i manganelli, ma fucili, lanciagranate ed esplosivo. Altri portano gli arredamenti della cella nel corridoio, perfino le brande. Altri ancora si mettono a divellere le porte blindate. In realtà un senso c’è, forse è il vero senso della rivolta, oltre tutte le nostre parole. È il senso della libertà riconquistata, anche se in un micro spazio, ma nel quale non ci sono più le regole vessatorie e puoi fare ciò che vuoi. Puoi modificarlo quello spazio, trasformarlo, plasmarlo a tuo piacere. Sono questi i termini della libertà negata che fa implodere le persone. Trasformare, modificare, riplasmare gli ambienti e le relazioni secondo i propri desideri. Sono atti liberatori, e più sono insensati più rispondono alla necessità di sentirsi, per qualche ora, liberi. Una libertà che avremmo pagato a caro prezzo.
«La conta» alle guardie – Da qualche ora alcuni simpaticissimi proletari prigionieri si aggirano al secondo piano. Chi ci fa caso, in quella baraonda? Tutti andiamo ovunque. Però si aggirano dalle parti delle tre celle dove abbiamo rinchiuso le guardie, ben controllate da C. che ha il pregio di non consentire deroghe a quanto stabilito in precedenza. Nessuno doveva avvicinarsi alle guardie, e così era. Dopo tanto tergiversare, alcuni ci vengono a proporre uno scherzo. Ma come? In quella situazione di tensione? Appunto, proprio in quel momento liberatorio, insomma, ci propongono che vorrebbero fare «la conta» alle guardie. Ossia riprodurre, a ruoli ribaltati, il rituale opprimente che i detenuti subiscono tutti i giorni per quattro volte al giorno: «la conta».
Normalmente si effettua la mattina dalle 6.00 alle 7.00, il pomeriggio dopo l’aria dalle 15.00 alle 16.00, la sera alle 23.00 e durante la notte. Quella della mattina e del pomeriggio viene effettuata, soprattutto negli «speciali», con le guardie che entrano in cella, battono le sbarre delle finestre, entrano nel bagno anche se stai facendo i tuoi bisogni, spesso ti perquisiscono e battono le sbarre anche durante la conta serale alle 23.00.
I buontemponi vogliono far provare alle guardie il piacere di questo rituale. Ne parliamo, se la cosa è una burla, si può fare. L’assicurazione è che sarà solo una carnevalata. I cinque detenuti indossano le divise delle guardie, già tolte agli agenti e sostituite con tute da ginnastica.
Anche il cappello si mettono, i burloni, ed entrano con fare serio nelle celle delle guardie. E chi se la perde ’sta scena? Tutti lì a sbirciare senza farsene accorgere, sennò la rappresentazione non funziona. Entrano col massimo della serietà e si schierano in posizione regolamentare, fanno le mosse regolamentari, perquisiscono gli agenti in tuta e battono le sbarre con una professionalità tale che pare abbiano fatto quel lavoro per tutta la vita, in realtà l’hanno subìto per gran parte della vita.
Il «pentimento» delle guardie – Dopo la vicenda della mancata telefonata alle famiglie, l’incazzatura delle guardie verso la direzione, e chi sta dall’altra parte, è massima. Ora chi si trova davanti la loro cella oppure, chi va a portar loro il piatto di pasta e le birre, deve sorbirsi le lamentele: «Ci usano per fare i loro comodi», dicono, «e poi, quando c’è da difenderci ci buttano via come uno straccio usato». È questo il senso dei loro discorsi. E giù a lamentarsi e a bestemmiare contro tutta la scala gerarchica del loro Corpo e il Ministero, fino al punto di dire: «Col cazzo che mi fregano più a fare ’sto mestiere di merda. Meglio il manovale, è più rispettato». Alt, ferma l’immagine. Idea grandiosa: e se queste loro parole le diffondiamo? Detto fatto. Carta e penna: «Scriveteli questi vostri pensieri che poi ci incarichiamo noi di farli arrivare a chi di dovere». Dopo qualche consulenza di lingua italiana, perché la scolarità delle guardie è scarsa, i pensieri vengono battuti a macchina. Diciotto firme in calce con nome, cognome, grado e numero di matricola, e alla fine la richiesta di dimissioni. Tutti firmano, e a qualcuno di loro i toni paiono perfino troppo morbidi.
L’incazzatura è dunque un grande strumento di conoscenza? Intanto al telefono l’attività del buon Giuliano, coadiuvato da affollati capannelli, produce il risultato di far venire alla rotonda del piano terra un avvocato per consegnargli il comunicato della rivolta con le nostre moderate richieste. Il problema principale è tenere la «folla» fuori dalla piccola stanza dove c’è il telefono. La «folla» è costituita da tutti quelli che passano di lì, il traffico è simile alla strada principale di un paese nell’ora dello «struscio».
Movimento nei corridoi – C’eravamo dati dei turni precisi nei luoghi dove era prevedibile arrivassero eventuali attacchi. Ed era la rotonda del piano terra, quella da cui era arrivate, dopo l’occupazione delle sezioni, le guardie in massa per cercare di riprendere il controllo del carcere. E le avevamo respinte. Dunque lì si fanno i turni di una decina di persone e con cambi molto frequenti, in media ogni ora. Ma lì non succede niente, è tutto silenzioso e la gran parte dei detenuti è invece attratta dall’attività brulicante nelle sezioni. Si gira, ci si incontra, si parla. E soprattutto si gravita intorno alla stanza del telefono per sapere le novità. Novità che non ci sono.
Altro punto di raduno sono le tv. Alcune di queste sono state portate nel corridoio e li intorno, con sgabelli e tavolini, si sono creati dei veri e propri ritrovi. Si prende il caffè, si chiacchiera commentando le notizie della tv, quelle regionali non parlano d’altro che della rivolta. Intervistano parenti e amici delle guardie sequestrate, guardie del carcere che in quel giorno non erano in servizio, altri operatori con varie funzioni. Ci si rende conto della miriade di interessi e relazioni che ruotano intorno a quel luogo. Si sente parlare tanta gente: dirigenti e dipendenti della ditta che fornisce gli alimenti; trasportatori che portano ogni mattina vari articoli nel carcere, dai giornali alle sigarette; fino ai lavoratori della nettezza urbana che prelevano l’immondizia. Poi ci sono familiari e amici dei detenuti comuni che stanno nel reparto «normale », distante dal luogo della rivolta. Ciascuno dice la sua. E sembra che tutti stanno dentro un film. Le loro parole non hanno nulla di reale. Quell’avvenimento ha rotto la monotonia della vita di una piccola città di provincia, e loro si sentono per la prima volta su un palcoscenico.
Capannelli, chiacchiere, tavolate di spaghetti. C’è allegria. Sembra strano, la tensione delle primissime ore ha lasciato il posto a una rilassatezza inaspettata. Perfino canzoni in coro, qualche slogan, quelli delle manifestazioni, oppure stornelli regionali nei diversi dialetti che attraversano un carcere speciale, dal bergamasco, al sardo, al genovese e al siciliano, e poi, veneto, milanese, alto atesino, e toscano, umbro, romanesco, calabrese, pugliese, napoletano, marchigiano, emiliano… sembra una festa, e forse lo è.
Ma una festa di inizio o una festa di fine?
Sia quel che sia, inizio o fine, in quel momento tutti lo viviamo come una festa con grande eccitazione. Al termine della giornata, a notte inoltrata, la tensione, il tanto muoversi, lo stress delle ore precedenti si fanno sentire. Verso l’una di notte qualcuno comincia a crollare, poi, man mano uno dopo l’altro cadono nel sonno quasi tutti. Sembra assurdo, stiamo facendo una rivolta, e la notte, si sa, è il momento più infido. Nelle prime ore dell’alba può venire un attacco. Hai voglia a richiamarli alla realtà, non ci si riesce, e come dopo una grande baldoria tutti cadono in un sonno pesante.
Restiamo si e no una decina e ci concentriamo in fondo alle scale a sorvegliare che non arrivino sgradite sorprese, tre vigilano davanti alle celle delle guardie. Andando avanti a caffè, sigarette, racconti e ricordi.
Sconfitti – Sconfitti? Forse sì, ma sarebbe stato indegno non ribellarci. Non solo in carcere, anche fuori. Sarebbe stato un crimine contro l’umanità accettare i silenzi conniventi, le ambiguità ammiccanti, i compromessi egoistici, l’accondiscendenza. Siamo stati ribelli, rivoltosi, sovversivi, rivoluzionari, terroristi, chiamateci come vi pare, ma siamo stati contro il vostro squallore. Quelli che sono rimasti immobili e passivi, quelli sono criminali.
Non tutta, ma una parte consistente della nostra generazione si è ribellata in ogni regione di questo mondo, quasi che ci si fosse dato un appuntamento. Bisognava dire stop agli equilibri politici, economici e militari che continuavano a produrre stragi, massacri, povertà, fame, sfruttamento e devastazione in molte aree del mondo, come se sessanta o settanta milioni di morti di qualche decennio prima non dovessero porre interrogativi importanti.
La rivolta, la nostra rivoluzione, non è bastata a fermare la macchina devastatrice imperialista, d’accordo, ma perlomeno ha stimolato genti a sollevarsi, a non più tacere. E poi, se non ci fosse stata quell’insorgenza, la dominazione brutale ve l’immaginate dove sarebbe arrivata? [pag.309]